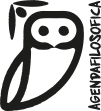di Massimo Iiritano*
Tra i vari momenti iconici con i quali sarà ricordato, ve n’è uno che in questi giorni sta tornando spesso, dal quale anche io vorrei partire. Si tratta della spettacolare preghiera del 30 marzo 2020 in una piazza S. Pietro deserta, buia e piovosa, in piena tempesta pandemica, con le sirene delle ambulanze in sottofondo. Riprendere le parole pronunciate in quella occasione, alle quali vi invito a tornare, significa infatti tentare la via di una lettura “teologica” del pontificato di Papa Francesco, che ci parla di un Dio vicino e solidale con la nostra sofferenza e con il nostro umano smarrimento, nella sua “impotenza” dinanzi al male.
Così, le tracce di riflessione disseminate qua e là sui limiti dell’Onnipotenza di Dio, sulla sofferenza innocente dei fanciulli, quelle tracce dostoevskijane che riemergevano a tratti nei suoi discorsi meno “teologici” e piu’ immediati, possono forse dirci oggi il senso profondo e la traccia inequivocabile di quello che è stato senza dubbio un Papa sconfitto. E per questo finalmente, autenticamente cristiano.
Le sue parole inascoltate sulla prossimità senza confini agli ultimi, ai migranti, ai detenuti; la sua vicinanza simbolica e reale a figure come Don Milani, Mimmo Lucano, Don Luigi Ciotti; sono le tracce vere che bisogna ricercare oggi, nel chiasso assordante degli elogi, dei rimpianti, delle ipocrisie trionfanti.
Papa Bergoglio non era questo. Era sì sempre accogliente, fino alla fine, anche contro voglia, anche dinanzi a chi come il vicepresidente Vance lo aveva sempre avversato e aveva rappresentato il perfetto contrario della sua visione del mondo e del cristianesimo. Accogliente, sorridente, ma mai ipocritamente accomodante. Sempre netto nei suoi giudizi, nel suo coraggio di prendere parte: la parte degli ultimi, la parte di Cristo. Quella destinata inesorabilmente, ancora, ad essere sconfitta e umiliata. Come la sua voce, i suoi richiami alla necessità del disarmo, della rinuncia alla violenza, dell’attenzione vigile ad ogni sopruso e ad ogni muro edificato dall’indifferenza.
Un Papa inascoltato, sostanzialmente, soprattutto da coloro che più oggi si commuovono dinanzi alla sua morte. Ma i segni sono potenti, e permangono. A partire dal nome, Francesco: primo papa “gioachimita” della storia che colma il vuoto secolare lasciato dalla gran rinuncia di Celestino V, tentando di far riemergere una traccia radicalmente alternativa a tutta quella che è stata la storia della Chiesa da Bonifacio VIII a Giovanni Paolo II. E obbedendo al segnale forte e inequivocabile che Benedetto XVI gli aveva lasciato in eredità. La sconfitta appunto, il coraggio di riconoscersi sconfitto.
Ed ecco allora che quel riconoscimento del limite, del male come ombra persistente nella creazione, diviene la via per un cristianesimo che torna a farsi testimonianza sofferente e sconfitta, che trova nella “tenerezza”, intesa appunto come il sapersi “tenue”, debole e vulnerabile dinanzi al male, la cifra di un insegnamento profetico che permane oggi come la sua più preziosa e innegabile eredità.
“La Chiesa di Cristo, che è suo corpo (cfr. Ef 1, 23), deve seguire la sorte di Gesù Cristo che ne è il capo (cfr. Ef 1, 22), deve cioè seguirlo nella morte, e come lui essere crocifissa nel mondo. Deve anch’essa morire nella storia per risuscitare poi come il suo Signore ed entrare con Lui nella gloria del Padre.
In questa morte culmina, e si consuma, il mistero dell’iniquità che domina l’intera storia del mondo” (S. Quinzio, Mysterium iniquitatis, Adelphi 1995, p. 86 s.).
*Massimo Iiritano, dottore di ricerca in Filosofia della religione, è stato docente incaricato di Antropologia delle religioni all’Università per Stranieri di Perugia, ha collaborato con la cattedra di Estetica dell’Università degli Studi di Perugia e con la cattedra di Filosofia delle religioni dell’ateneo di Siena-Arezzo. Attualmente è docente di filosofia al Liceo Classico Galluppi di Catanzaro. Insegna Istituzioni di storia della filosofia e filosofia dell’educazione all’Istituto Universitario Giorgio Pratesi e collabora alla cattedra di filosofia morale dell’Università della Calabria. È presidente dell’associazione nazionale Amica Sofia ed è stato allievo e collaboratore, tra gli altri, di Sergio Quinzio, Bruno Forte, Sergio Givone e Massimo Cacciari.